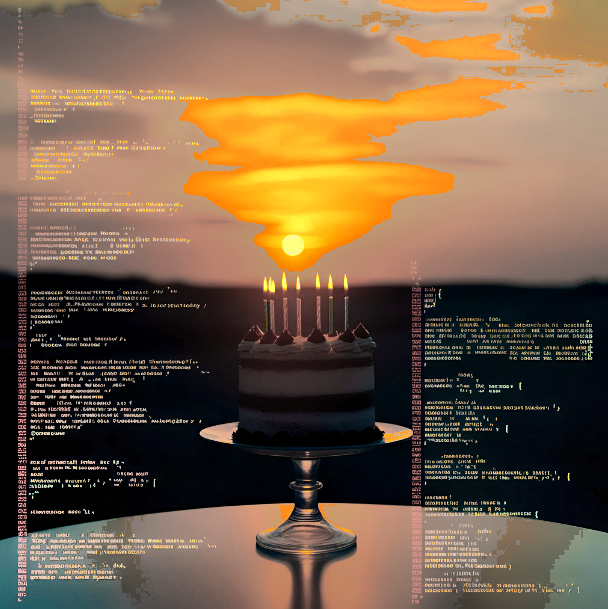Il nome della cosa: una rassegna critica (2025)
Negli ultimi trent’anni l’affermazione delle tecnologie digitali, l’uso estensivo dei social e il relativo ricorso massivo alla produzione di immagini via smartphone, ha determinato un inedito scenario connotato da una frattura radicale nei modi di produzione, circolazione e fruizione delle immagini del mondo. Questo stato di cose ha innescato un’ampia riflessione relativa al loro possibile statuto di descrizioni o rappresentazioni del reale, quindi sul loro valore di testimonianza veridica e affidabile; quella che al tempo della fotografia (ottico chimica: analogica) si fondava sul riconoscimento del suo valore indicale di traccia; sulla sua ineluttabile certificazione (in modi culturalmente e tecnologicamente variati), che ciò che essa mostrava era – inevitabilmente – stato. Per indicare questo nuovo scenario fatto di immagini ubique e smaterializzate (almeno percettivamente), che possono avere una sempre più labile relazione causale con il rappresentato, si è fatto ricorso a termini diversi, tra i quali è prevalso quello di “postfotografico”. Il suo successo mediatico e accademico sembra però avere basi più convenzionali che sostanziali; frutto poco meditato di una riflessione tanto ampia quanto, a volte, superficiale o non criticamente fondata delle caratteristiche distintive di questo ambiente e delle immagini che lo popolano. Particolarmente insoddisfacente risulta in particolare la verifica teorica delle conseguenze derivate dal confronto con le modalità fotografiche di registrazione e rappresentazione, rispetto alle quali non è stata colta o sufficientemente considerata la frattura ontologica che distingue le immagini digitali, sebbene queste siano considerate anche come raffigurazioni del possibile.
Sintomo evidente di questa insufficienza pare essere proprio la proposta terminologica, che col risolvere l’identificazione nominale ricorrendo all’apposizione del prefisso “post”, oltre ad esprimere (paradossalmente) un sentimento nostalgico, offre implicitamente un’interpretazione evoluzionistica, quasi ‘naturale’ (natura non facit saltus) del fenomeno e delle sue figure, celando le radicali, paradigmatiche differenze tra queste categorie di immagini, nonostante le superficiali apparenze. Nelle pagine che seguono si è tentato di dar conto della pluralità di posizioni, a volte anche intrinsecamente contraddittorie o non risolte, che hanno contribuito al dibattito ancora in corso sulla natura e le caratteristiche di queste immagini digitali che ci appaiono come fotografie ma sono elaborate da algoritmi. Lo si è fatto cercando di lasciare il maggior spazio possibile alle singole voci autoriali, affidando al disegno della loro messa a registro e a confronto l’esplicitazione della posizione critica di chi scrive, nella speranza che questo breve testo possa contribuire a precisare il percorso che deve necessariamente portare a meglio definire le caratteristiche ontologiche di queste immagini già nuove, inedite, e per conseguenza individuare (inventare o forse scoprire) il termine più adatto per identificarle: per riuscire infine a trovare il nome della cosa.
§§§§§
Prima del post: l’immagine digitale
Il termine postfotografia, come è noto, venne introdotto da David Tomas nel 1988 per indicare una “‘pratica post-fotografica’ radicalmente diversa da quella corrente, basata su un approccio ecologico alla produzione di immagini in una certa cultura”[1]; qualcosa quindi di paradigmaticamente diverso dall’accezione che lo stesso termine ha assunto dopo la svolta digitale e forse influenzato dalle riflessioni di Vilém Flusser (1986), che qualificava le fotografie come “oggetti della cultura postindustriale, in cui il lavoro è svolto da apparati automatici”. Tomas si concentrava sul compito da assegnare a una “postfotografia” ancora e inevitabilmente analogica: quello di esplorare e trasformare “criticamente i contesti storici e contemporanei che definiscono l’attuale produzione di immagini in una cultura.” Nulla a che vedere quindi – in termini di senso e di significato – con l’adozione di poco successiva dello stesso termine da parte di William J. Mitchell (1992), né tanto meno con la fortuna che esso ha assunto nella pubblicistica come nella riflessione teorica degli ultimi anni. Proprio in apertura del suo saggio Mitchell notava che “potremmo scegliere di considerare l’immagine digitalmente codificata semplicemente come una nuova forma non chimica di fotografia, proprio come l’automobile era inizialmente vista come una carrozza senza cavalli… Ma tali metafore oscurano l’importanza di questo nuovo modello informazionale e le sue vaste conseguenze per la cultura visiva. Sebbene un’immagine digitale possa apparire proprio come una fotografia quando viene pubblicata su un giornale, in realtà differisce dalle fotografie tradizionali tanto profondamente quanto una fotografia da un dipinto”[2], poiché muta radicalmente la modalità di iscrizione: “dalla fotografia come trascrizione della luce sulla superficie di un materiale fotosensibile alla fotografia quale traduzione della luce in dati digitali” (Palmer 2015).
Non interessa qui ripercorrere l’epistemologia “apocalittica” (Coulombe 2016) di Mitchell, che dalla radicale messa in discussione della capacità indicale della fotografia conduceva a quello che – con altrettanta fortuna mediatica – definiva un regime di “post verità”; ci limiteremo semmai a rilevarne le implicazioni ontologiche sottese alla relazione oppositiva fotografia/ dipinto, ovvero immagine analogica/ immagine digitale. Stabilito che “le fotografie sono epistemologicamente realistiche perché sono informatori affidabili in merito alle proprietà visive dei loro depicta. (…) [e] sono anche ontologicamente realistiche perché sono causalmente connesse ai loro depicta, [ne deriva che] per quanto diverse possano essere queste definizioni di realismo fotografico, esse sono intrecciate: il realismo epistemologico dipende dal realismo ontologico. Solo perché il contenuto informativo della fotografia è prodotto causalmente, la consideriamo un riflesso estremamente veritiero del mondo visivo” (Gooskens 2012).
potremmo scegliere di considerare l’immagine digitalmente codificata semplicemente come una nuova forma non chimica di fotografia
Come ha rilevato Antonio Somaini (2016: 147), da questo fondamentale punto di vista la distinzione tra fotografia e immagine digitale è netta: “anche se in entrambi i casi all’origine dell’immagine vi è un’esposizione alla luce, nel primo caso abbiamo delle immagini-impronta o immagini-traccia, isomorfiche rispetto ai loro referenti esterni e prodotte in modo analogico, attraverso una serie di passaggi ottici e chimici, dall’incontro tra una superficie fotosensibile e i riflessi di luce provenienti da ciò che si è trovato in un determinato istante di fronte all’obiettivo; nel secondo caso abbiamo invece delle immagini in cui il contatto con la realtà è mediato dall’intervento di una forma di codificazione digitale dei segnali luminosi ed eventualmente di compressione secondo gli standard di un determinato formato”[3].
Geoffrey Batchen (1994) aveva invece posto la questione in altri termini, che potremmo forse etichettare come postmodernisti, prendendo in considerazione la possibilità che “le fotografie stesse fossero mai state altro che simulazioni. Se, ad esempio, osserviamo attentamente la relazione indicale della fotografia con la realtà, la caratteristica che presumibilmente la distingue dall’immagine digitale, scopriamo che anche questa [la fotografia] non implica altro che una «segnatura di segni». In altre parole, la fotografia si rivela essere un altro processo digitale; ripresenta una realtà che è già di per sé nient’altro che un gioco di rappresentazioni. In ogni caso, le fotografie sono trasformazioni in immagine di un mondo tridimensionale, immagini che dipendono per la loro leggibilità da un insieme di convenzioni visive storicamente determinate. (…) Di fatto, per ora, le immagini digitali rimangono dipendenti dai modi fotografici di vedere, non il contrario”.
Un modo raffinato di interrogarsi sullo statuto di veridicità della fotografia (analogica), sebbene in sostanza la questione nodale non sia questa. Semmai il confronto oppositivo tra la relazione con l’indispensabile presenza di ciò che è stato davanti al materiale fotosensibile (la referenza, sulla quale si è interrogato Jacques Derrida ([1981] 2010) e “la produzione di immagini ‘fotografiche’ che non hanno alcun referente specifico o causale nel mondo degli oggetti e degli eventi” (Lister 1995 a). Da qui la necessità di interrogarsi sul valore epistemologico e quindi etico di queste nuove figure, nelle quali il regime di verità attribuito all’immagine traccia indicale è sostituito fenomenologicamente e attivamente dall’effetto di verosimiglianza privo di relazioni causali proprio delle immagini rappresentazionali[4]. Con questo passaggio si è chiusa quella che Pierre Barboza (1996: 34) ha efficacemente definito come “la parentesi indicale nella storia delle immagini”, per aprire quella “post-fotografica”, riconoscendo cioè che la fotografia analogica è “un costrutto dell’era digitale” (Cullen 2024). Affermazione storicamente condivisibile, illuminante nella sua sostanza pleonastica e già avanzata in diversa prospettiva da Servanne Monjour (2018 a), per la quale “il digitale avrebbe generato in parte, e retroattivamente, la fotografia argentica. Per definire questo fenomeno complesso e anacronistico di rimediazione[5] ‘a ritroso’, proponiamo il concetto di retromediazione.”
L’interesse per le forme storiche sarebbe così “riconducibile alla nozione stessa di ‘postfotografia’, nella misura in cui essa richiede, attraverso il suo prefisso, di pensare il contemporaneo nella condizione temporale di una conseguenza. Questa è una posizione ampiamente condivisa nel disilluso contesto di un postmodernismo avvinto nella ripetizione infinita dell’uguale o in un vertiginoso movimento di differenze, affogando in ogni caso la coscienza storica in infiniti dopo. Ma possiamo anche considerarlo diversamente, come un lampo, vale a dire uno di questi incontri dialettici della storia tra l’Allora e l’Adesso” (Han 2016) di cui aveva scritto Walter Benjamin.
una «segnatura di segni»
In quegli anni di fecondo dibattito la questione del ruolo centrale della storicità delle convenzioni rappresentative come elemento dirimente nella distinzione analogico/ digitale, già richiamata da Batchen, venne affrontata da Lev Manovich (1996), che si chiedeva se “le fotografie digitali funzionano in un modo completamente diverso dalle fotografie tradizionali oppure no? Dobbiamo accettare il fatto che l’immagine digitale rappresenti una rottura radicale con la fotografia? (…) Il fenomeno dell’immagine digitale ci costringerà a ripensare concetti fondamentali come realismo o rappresentazione? (…) La logica della fotografia digitale è una di continuità e discontinuità storica. L’immagine digitale lacera la rete di codici semiotici, modalità di visualizzazione e modelli di spettatori nella moderna cultura visiva e, allo stesso tempo, tesse questa rete ancora più forte. L’immagine digitale annienta la fotografia mentre consolida, glorifica e immortala la fotografia. In breve, questa logica è quella della fotografia dopo la fotografia. (…) sicuramente, ciò che l’imaging digitale preserva e propaga non sono altro che i codici culturali del film o della fotografia. (…) Se ci limitiamo a concentrarci esclusivamente, come fa Mitchell, sui principi astratti dell’immagine digitale, allora la differenza tra questa e una fotografica appare enorme. Ma se consideriamo le concrete tecnologie digitali e i loro usi, la differenza scompare. La fotografia digitale semplicemente non esiste.” Ad analoghe conclusioni giungeva anche Tom Gunning (2006), al quale “tacciare il digitale come ‘post-fotografico’ [sembrava] non solo più polemico che descrittivo, ma anche relativamente criptico. Il trasferimento dell’informazione fotografica in un sistema basato sui numeri rappresenta certamente una tappa rivoluzionaria nella fotografia, ma non più della sostituzione del processo al collodio umido con la lastra secca (…). Proprio come queste prime mutazioni della fotografia, la rivoluzione digitale cambierà il modo in cui scattiamo le foto, anche chi le scatta e per quali scopi, ma le foto rimarranno foto.”
Certo se fosse vero che “le foto rimarranno foto” non ci sarebbe ragione di porsi questioni ontologiche, ma non tutti concordano con queste semplificazioni e molti si chiedono – ancora – cosa sia una fotografia e da qui sarà necessario procedere, nella convinzione che l’immagine digitale non è – in termini ontologici – una variante tipologica della fotografia. Per procedere oltre è opportuno considerare la questione del realismo rappresentativo della nuova categoria di figure, nella consapevolezza che “un’immagine digitale agisce (appare) come una fotografia non perché ha una relazione ontologica e causale con una cosa (ad esempio, l’oggetto fotografico); lo fa perché (…) i dati registrati dal sensore sono elaborati algoritmicamente in modo da essere percepiti dagli esseri umani come una fotografia” (Değirmenci 2017), al fine di produrre quella che Paul Willemen (2002: 20) ha opportunamente definito “una sensazione di indessicalità”. Quella che proviamo comunemente guardando e riguardando le immagini di un progetto come The Book of Veles di Jonas Bendiksen (2021). Una conferma della crescente impossibilità (ma solo contingente, ne sono certo: oggi nessuno più fugge terrorizzato di fronte all’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat) di distinguere tra fotografie e immagini che ne simulano l’apparenza[6], affidandosi proprio a quel codice rappresentativo convenzionalmente più verosimile e socialmente condiviso che è il realismo mimetico.
il fenomeno dell’immagine digitale ci costringerà a ripensare concetti fondamentali come realismo o rappresentazione
Peter Osborne ricordava a questo proposito che “la fotografia, così come l’arte, [è] un concetto storico, soggetto agli sviluppi interconnessi delle tecnologie e delle forme culturali”[7], spingendosi però sino al punto di comprendere in questo termine la “totalità storica delle forme fotografiche, o tipi di immagini prodotte in un modo o nell’altro dall’iscrizione della luce: prevalentemente, fino a poco tempo fa, la fotografia chimica naturalmente, ma anche il cinema, la televisione, il video e ora – assolutamente – la fotografia digitale, così come la fotocopia e la scansione, e persino le immagini a microonde, a infrarossi, ultravioletti e radio a onde corte”. Un “emporio celestial” per dirla con Borges (1942), a cui mancava solo la traccia dell’abbronzatura sulla pelle per essere completo; un mare in cui annegava ogni particolarità distintiva e funzionale. Nello stesso, inaugurale numero di “Philosophy of Photography” compariva la ben più interessante proposta di Ariella Azoulay per una “ontologia politica” della fotografia, da lei già definita come “il prodotto dell’incontro di protagonisti diversi: in primis il fotografo e il fotografato, l’apparecchio fotografico e lo spettatore”[8]. Una concezione della fotografia (come pratica e come immagine: come oggetto sociale) che sembrava voler riunire il modello dialogico di Bachtin (cfr. Todorov [1981]1990), la cooperazione interpretativa di Eco (1979) e le riflessioni sull’apparato fotografico di Flusser ([1983] 1987 a). Da qui la constatazione problematica e feconda che “la maggior parte di, se non tutti coloro che intendono esaminare l’ontologia della fotografia (…) non sono consapevoli del fatto che ciò che designano come oggetto di discussione deriva dallo specifico campo di discorso di cui essi fanno parte (…). Inquadrare discorsivamente la fotografia in base all'(in)accessibilità della fotografia stessa cancella la discussione sulla fotografia ancor prima che inizi” (Azoulay 2010). Ancora più esplicita e gravida di conseguenze la posizione di Daniel Rubinstein e Katrina Sluis, per i quali “secondo il modello dialogico non può mai esserci un’interpretazione finale e definitiva di nessuna immagine perché in ogni nuova situazione, in ogni nuovo incontro con un pubblico o con degli spettatori, l’immagine acquisirà nuove interpretazioni e significati. Un’immagine non riceve il suo significato dalla sua indicalità né dalla sua iconicità, ma dalla rete di relazioni che la circonda”[9]. Sebbene gli autori si riferissero qui esplicitamente alla “networked image“, mi pare che l’affermazione contenesse un’intenzione più generale di disconoscimento di quel valore indicale che pure ha fondato il ruolo storicamente definito delle immagini fotografiche. È certo determinante (e ormai quasi scontato) porsi il problema delle condizioni storiche, sociali, culturali e politiche di chi guarda (l’autore e lo spettatore), ma lo è altrettanto quello di stabilire e comprendere le caratteristiche culturali e produttive, sostanzialmente ontologiche, di ciò che viene guardato; di chiedersi ad esempio, e per iniziare, se e perché l’immagine digitale non sia altro che una specie di trompe l’œil o addirittura una “allegoria”[10]; un’immagine che simula le connotazioni di una fotografia allo scopo di assumerne e condividerne lo statuto di traccia indicale veridittiva. Una mise en abyme mimetica; l’immagine di una “immagine [che] è mimesis, imitazione più o meno fedele di una realtà che le pre-esiste (…) e che sussiste indipendentemente dall’immagine che la raffigura” (Pinotti 2021: xiii), dove “la somiglianza è produttiva [poiché] i rapporti tra gli elementi di una cosa passano direttamente tra gli elementi di un’altra cosa, che sarà poi l’immagine della prima” (Deleuze [1981] 2023: 108), anche nel caso in cui questa fosse già a sua volta un’immagine.
chiedersi ad esempio, e per iniziare, se e perché l’immagine digitale
non sia altro che una specie di trompe l’œil o addirittura una allegoria
Se è però vero, come scrisse Jean Baudrillard ([1995] 1996: 13), che “nel lenzuolo funebre del virtuale il cadavere del reale è definitivamente introvabile [perché] viviamo in un mondo in cui la suprema funzione del segno è quella di far scomparire la realtà e di mascherare nel contempo questa scomparsa”, allora un’immagine digitale diventa il simulacro di una fotografia sotto il duplice aspetto della perfetta realizzazione dell’annullamento di ogni distinzione tra originale e copia e della sua apparenza percettiva, poiché “il paradosso della svolta algoritmica (…) è che mentre l’immagine diventa indecidibile e il suo significato sempre più sfuggente, essa diventa anche più visualmente seducente e tattile” (Rubinstein, Sluis 2013: 34).
Già Mitchell (1992: 4) aveva fatto notare che “un’immagine digitale può apparire proprio come una fotografia”, seguito di lì a poco da altri autori che parlavano di “immagini in stile fotografico” (Batchen 1994), o – in modo più pertinente – di “simulazione digitale di fotografie ‘chimiche'”[11]. Più di recente (e maggiormente attrezzati) si è riconosciuto che “l’immagine digitale nativa è composta da un insieme di dati che ha l’aspetto di una fotografia analogica solo per convenzione. In quanto dati, le immagini non sono più definite dalla loro modalità di registrazione o dalla loro costruzione geometrica, ma dalla struttura algoritmica che conferisce loro un qualsiasi aspetto particolare” (Hoelzl, Marie 2015: 131); ovvero “quando i computer guardano una fotografia non vedono zia Helena, un tramonto o una torta di compleanno [ma] informazioni calcolabili” (Rubinstein 2013: 34). Ciò vuol dire che “un’immagine sullo schermo di uno smartphone o di un laptop sembra una fotografia non perché ha una qualche relazione ontologica con un oggetto nel mondo, ma a causa di interventi algoritmici che assicurano che ciò che viene registrato sul sensore CCD/CMOS della fotocamera venga infine restituito come qualcosa che un essere umano potrebbe riconoscere come una fotografia” (Rubinstein, Sluis 2013: 28), rivelando infine tutto il costrutto culturale di questi esiti ormai abitati anche dalle “immagini generative”, prodotte da apparati completamente artificiali ma che hanno un’apparenza reale[12]. Immagini che simulano caratteristiche indicali, prodotto di un apparato del quale l’utilizzatore ignora felicemente i principi e le dinamiche di funzionamento, poiché “la materialità dell’immagine digitale è profondamente combinata con la sua intrinseca indecidibilità e sostenuta da processi computazionali che sono in gran parte inconoscibili o inaccessibili. (…) il punto cruciale è che l’intelligenza che fa funzionare la rete non è (o almeno non interamente) semplicemente umana. Per questo motivo sosteniamo che la materialità dell’immagine digitale non si trova nella sua aderenza indicale agli oggetti del mondo”[13].
quando i computer guardano una fotografia non vedono zia Helena, un tramonto o una torta di compleanno, ma informazioni calcolabili
§§§§§
La condizione post digitale
Nel corso di un’intervista di una decina di anni fa (in Palmiéri 2014), Juan Fontcuberta rifletteva sulle connotazioni complesse di quella situazione post-fotografica che avrebbe indagato nella veste di curatore del Mois de la Photo di Montreal[14] dell’anno successivo: “Possiamo constatare che ci troviamo in una seconda ondata, vale a dire, per quel che riguarda le conseguenze tecnologiche, quella che ci porta verso immagini smaterializzate. Immagini il cui supporto ha perso importanza. Vivono sullo schermo del computer, sono qui, lì e da nessuna parte. Questa ubiquità dell’immagine è possibile perché essa non ha più alcuna materialità, che è ciò che ne permette la circolazione. Questa seconda rivoluzione digitale è stata la conseguenza dell’accresciuta rilevanza di Internet, dei social network, della telefonia mobile, dell’onnipresenza delle telecamere di sorveglianza e naturalmente della produzione di massa di immagini. Siamo arrivati al punto in cui fotografiamo di tutto e in continuazione, così che – paradossalmente – passiamo tutto il tempo a scattare e non ne abbiamo più a sufficienza per guardare. Abbiamo invertito il processo perché ciò che ora ci interessa non è più l’immagine come risultato, ma il gesto fotografico come atto relazionale di comunicazione. Ciò trasforma il ruolo funzionale della foto e la sua stessa natura. (…) è tramontata l’idea di lasciare traccia del nostro momento storico, della nostra memoria, dei nostri interessi, delle nostre passioni. Sono tutte queste trasformazioni e metamorfosi che si verificano nel campo della cultura visiva che devono essere messe in discussione.” Un’utile guida alla comprensione di questa condizione complessa e dei fenomeni che la costituiscono può essere individuata nei contributi compresi in un recente volume curato da Barbara Grespi e Federica Villa, nel quale ci si propone di osservare “l’immagine (post)fotografica contemporanea a partire da questi due poli che la alimentano e la definiscono: da un lato la macchina del digitale avanzato, che ha trasformato profondamente il modo di produzione, circolazione e fruizione delle fotografie, dall’altro le pratiche d’uso, le «posizioni» di sguardo e di intervento sulle tracce, senza le quali le immagini non acquisiscono un’esistenza nello spazio sociale. (…) Il postfotografico è una certa tendenza dell’immagine contemporanea, ma anche un complessivo scenario intermediale. Non coincide con l’idea di postfotografia (…) ma si propone di estenderla agganciando le questioni emerse nella prima fase della digitalizzazione con quelle contemporanee dell’era virtuale e algoritmica” (Grespi, Villa 2024: 3). Un’era nella quale, “quando non è nascosta all’interno del gesto postfotografico (con l’intelligenza artificiale al lavoro dentro lo smartphone), la rivoluzione algoritmica sembra rendere obsoleto il concetto stesso del fotografare, cioè l’impiego di dispositivi di raccolta e scrittura della luce, dato che consente di creare immagini fotorealistiche direttamente dai dati” (Grespi 2024 c: 179). Accade così che in quello che viene definito il contesto post-fotografico “le precedenti concezioni dell’immagine fotografica come unità semantica indicale, discreta e circoscritta (enframed) risultano sempre più inadeguate quando ci si confronta con la rete, con la sua mancanza di confini, la sua simultaneità e processualità. Una conseguenza importante della diffusione della fotografia nella rete informatica è che non è più chiaro ‘dove’ si trovi l’immagine. Online non c’è un punto in cui l’immagine finisce; semmai c’è una successione infinita di costellazioni temporanee di immagini, tenute insieme da una certa correlazione di metadati, distribuzione di pixel o ricerche booleane. Le stesse tecnologie che sottolineano la veridicità della rappresentazione producono anche le possibilità di duplicazione seriale. (…).
il postfotografico è una certa tendenza dell’immagine contemporanea, ma anche un complessivo scenario intermediale
Resta la domanda, per l’artista, il curatore, l’archivista, il filosofo: dov’è l’immagine? (…) Poiché l’immagine è continua, senza cornice, multipla e processuale, non può essere affrontata con gli strumenti della semiotica e dello strutturalismo che sono stati sviluppati per gestire immagini finite, circoscritte, singolari e statiche” (Rubinstein, Sluis 2013: 30-31). La smaterializzazione risulta perciò essere la condizione comune delle nuove forme di esistenza e d’uso di queste “immagini numeriche in regime post-fotografico” (Langford, Lavoie 2016). Una definizione che già distingue nominalmente contesto di produzione/ circolazione e tipologia delle immagini che alcuni chiamano post-fotografie ed altri postfotografie (o alternando indifferentemente i due termini), così mostrando che si tratta (anche) di una questione di tratto (e forse di tatto, non in senso aptico ma di sensibilità). Perché ci dovrà pur essere una differenza tra “postfotografia” e “post-fotografia”, quando il termine “oltre ad essere un indicatore del passaggio dall’analogico al digitale, è arrivato a designare sia una periodizzazione storica (l’era post-fotografica) sia una cultura paradigmatica dell’immagine, che impone determinate condizioni di intelligibilità a qualsiasi rappresentazione (l’immagine post-fotografica come categoria semantica, in contrapposizione a quella fotografica kraussiana)”[15]. Il filosofico post, si potrebbe dire, avviato dal post strutturalismo e dal postmoderno; proseguito con la post storia, il post umano[16], e poi il post-pittorico certo, senza dimenticare però, al postutto, quel postelegrafonico che tanto sarebbe piaciuto a Totò. Non si può che constatare, qui, la pervasiva fortuna del termine che ne impone quindi l’accoglimento se non l’accettazione in termini culturali, ma credo sia necessario almeno richiamare il fatto che sarebbe più corretto parlare non di post fotografia ma di immagini prodotte e fruite in ambiente post digitale[17], quello ” in cui la logica del digitale ha dato origine a una mentalità digitale e permea quasi ogni aspetto dell’esistenza umana” (Kölmel, Ströbele 2013: 16); quello in cui la qualificazione di ‘digitale’ “cessa di indicare una differenza e diventa semplicemente lo stato o la condizione predefinita” (Cramer, Jandrić 2021). Alcuni anni orsono Fontcuberta ( [2016] 2018: 3) aveva affermato che “la postfotografia fa riferimento alla fotografia che fluisce nello spazio ibrido della socialità digitale e che è conseguenza della sovrabbondanza visuale. Quel villaggio globale profetizzato da Marshall McLuhan s’inscrive nell’iconosfera, che oggi non è più una mera astrazione allegorica: abitiamo l’immagine e l’immagine ci abita (…). ‘Post’ indica l’abbandono o l’allontanamento. (…) Il prefisso ‘post’ evoca anche un addio. (…) Guardando in prospettiva alla parola ‘postfotografia’, siamo accecati dal guardare nel retrovisore ciò che lasciamo indietro e ignoriamo quello che ci si para davanti. E questo è un errore strategico, quando non addirittura una goffaggine. Perché la parola ‘postfotografia’ finisce per rappresentare non ciò che è, ma solamente ciò che non è. E in questo senso è il riflesso di un fallimento: non tanto quello del linguaggio o della classificazione, nella sua ossessione nominalista, quanto quello di un certo atteggiamento nostalgico e smarrito”. Atteggiamento che riconosciamo però in altre sue affermazioni di poco precedenti, che non solo definivano “la postfotografia [come] ciò che resta della fotografia”[18], ma si accompagnavano alla constatazione apparentemente contraddittoria del fatto che non si sentiva “troppo a suo agio con il termine post- che, infatti, si riferisce alla fine. Sarebbe come dire addio alla fotografia. D’altro canto penso che permetta di aprire una porta per entrare o uscire. Ciò che è importante è l’aspetto positivo che ci si attende da questo avvio.” (Fontcuberta in Palmiéri 2014).
online non c’è un punto in cui l’immagine finisce
Sarebbe questa la condizione post-fotografica, questa cosa che “non è uno stile, un movimento o un periodo storico” ma uno scenario popolato di “fotografie aumentate” (De Kerckhove 2015); segnato dal primato della virtualità, che assume la forma di “uno schermo luminoso che ha un lato rivolto verso l’uomo (…) e l’altro lato collegato in remoto a un flusso inimmaginabile di dati che viene costantemente elaborato e rielaborato da algoritmi (…). Di tanto in tanto questi algoritmi estraggono alcuni pacchetti di dati (…) e danno loro una forma visiva che assomiglia a ciò che eravamo soliti chiamare ‘una fotografia’. Ma questa somiglianza è superficiale, per usare un eufemismo. (…) la parola ‘fotografia’ oggi non designa un’altra forma visiva di rappresentazione, ma un’economia immersiva, che offre un modo completamente nuovo di abitare la materialità e la sua relazione con corpi, macchine e cervelli. (…) la fotografia [è] l’incarnazione visiva dell’algoritmo” (Rubinstein 2015). Soprattutto – come ha chiarito Monjour (2018 b) – questa nuova tipologia di immagini “è scrittura. Scrittura che si può cancellare e riscrivere, come un palinsesto. Le conseguenze sono potenzialmente notevoli per la fotografia: ciò che vediamo, quando guardiamo un’immagine, è infatti solo una ‘traduzione’ visiva del codice, indecifrabile come tale, ma facilmente corruttibile.”
Siamo quindi di fronte a quello che si può a ragione definire come un cambiamento di paradigma (non solo o non immediatamente epistemologico), che – al di là delle più superficiali e fenomenologiche apparenze – introduce modalità e concetti incommensurabili, anche se qualcuno ha sostenuto che “la transizione digitale ha avuto un impatto solo marginale sulle pratiche visive. Contrariamente alle più fosche previsioni, i giornali hanno continuato a pubblicare reportage illustrati e i genitori continuano a fotografare i loro figli. Come un’automobile che ha sostituito il motore termico con uno elettrico, la fotografia ha conservato la maggior parte delle sue funzioni. Non si è verificata alcuna catastrofe visibile, ma più prosaicamente si è assistito a un’accelerazione della razionalizzazione del settore” (Gunthert 2014). Per altri (e sono la più parte) si è invece trattato di qualcosa di ben più profondo e radicale di una semplice razionalizzazione, perché “anche se utilizziamo gli stessi strumenti come la macchina fotografica con i suoi obiettivi, il carico di valori ideologici dell’immagine come i concetti di memoria, verità, identità risulta condiviso con altri interessi. La fotografia è entrata nel circuito comunicativo più quotidiano: la inviamo e poi la cancelliamo. È entrata in uno spazio conversazionale. Viene utilizzata come elemento di connettività con gli altri. Non le viene più attribuito il dovere della memoria, come accadeva nella fotografia tradizionale, per la quale si sviluppò un’ossessione per la verità. Oggi le scelte sono molteplici. Viene da chiedersi se si tratti ancora di fotografia o se, a poco a poco, si stia trasformando in qualcos’altro. Il corpo è ancora lì, ma l’anima non è più quella di una volta” (Fontcuberta in Palmiéri2014). Più in particolare, più propriamente, “ciò che è davvero rivoluzionario nell’avvento delle immagini digitali è il fatto che esse sono essenzialmente leggibili dalle macchine: possono essere viste dagli umani solo in determinate circostanze e per brevi periodi di tempo. Una fotografia scattata con un telefono crea un file leggibile dalla macchina[19], ma non riflette la luce in una forma percepibile all’occhio umano. Un’applicazione secondaria, come un software per la visualizzazione di immagini associato a uno schermo a cristalli liquidi retroilluminato, può creare qualcosa che l’occhio umano può osservare, ma l’immagine appare solo temporaneamente prima di trasformarsi di nuovo nella sua forma meccanica immateriale quando il telefono viene messo via, o lo schermo è spento. Tuttavia, l’immagine non ha bisogno di essere leggibile agli umani affinché una macchina possa utilizzarla” (Paglen [2016] 2022: 43).
una fotografia scattata con un telefono crea un file leggibile dalla macchina,
ma non riflette la luce in una forma percepibile all’occhio umano
Dal punto di vista delle modalità rappresentative sarebbe “l‘imaging scientifico – cioè la messa in immagine di dati sperimentali e costrutti matematici – (…) il modello della nuova fotografia, che non deve essere ritenuta del tutto disancorata dalla materia del reale (…), ma va riconosciuta come immagine modellata su indici della realtà più estesi, sia in senso quantitativo che qualitativo” (Grespi 2024 a: 13); indici che quindi non sarebbero più da intendersi come tracce in senso peirciano, ma piuttosto rappresentazioni codificate di un qualche aspetto del reale, così che in termini di visualizzazione di dati reali non ci sarebbero differenze sostanziali tra un’immagine ‘fotografica’, una bilancia, un diagramma a torta o un termometro. L’impressione, forte, è quella di trovarsi di fronte a un contesto discorsivo e narrativo nel quale il termine fotografia assume funzione solo metaforica, qualcosa di analogo al dire – ad esempio – “l’ultimo rilevamento ISTAT fornisce una fotografia della società italiana”. Se concordiamo sul fatto che “il dispositivo non produce scatti ma flussi di dati”[20], allora “la post-fotografia non richiede un apparecchio di ripresa per creare un’immagine, [ma] produce un’immagine a partire da una collezione di dati pre-esistenti”[21], ciò che – mi pare – conferma e quasi certifica la distinzione paradigmatica, incommensurabile tra fotografia e immagine digitale, pur nelle sue diverse e distinte accezioni (se non definizioni).
Resta allora da chiedersi, e non è questione di poco conto, cosa accade quando “slittando dalla traccia al tracciato, l’immagine pretende di essere scrittura, allo stesso modo della letteratura. Ma tra questa deindicizzazione ormai diffusa e il trionfo dell’approccio metafotografico, cosa succede allo statuto ontologico dell’immagine? La fotografia ha rinunciato definitivamente a ogni esigenza euristica di rivelazione?” (Monjour 2018 c). Messi di fronte allo scarto tra iscrizione e scrittura è necessario provarsi a fare chiarezza, a partire dalla troppo semplicistica e strumentale adozione di fungibilità terminologica tra ‘immagine’ e ‘fotografia’, disconoscendo le specificità dello statuto ontologico di quest’ultima. Per procedere oltre sarà allora necessario provarsi a verificare una delle questioni centrali dello statuto della fotografia (analogica), quello della relazione causale della traccia, dell’indicalità o indessicalità, essendo l’altro (sul quale torneremo) quello dell’irreversibilità della registrazione della traccia stessa.
§§§§§
La scomparsa dell’indice[22]
Con una efficace sintesi Kris Paulsen (2018) ricordava che “quando le tecnologie digitali divennero comuni negli anni Novanta e la già tenue materialità della fotografia analogica (particelle di luce che toccavano l’emulsione) divenne ancora più attenuata (sensori elettronici che leggevano e traducevano informazioni ambientali), l’indessicalità e la qualità probatoria della fotografia furono messe in discussione. Senza il contatto fisico, alcuni temevano che la fotografia avrebbe perso la sua indessicalità e la sua certezza probatoria. Inoltre, le tecnologie digitali stavano diventando così brave a simulare l’aspetto delle fotografie o ad alterare invisibilmente le immagini fotografiche che non c’era più modo di comprendere qualsiasi immagine fotografica come nient’altro che un’icona con poca relazione necessaria con la realtà esistenziale. Di conseguenza, i teorici dei nuovi media (…) annunciarono l’apparente ‘morte’ dell’indice fotografico.”
Queste varie annunciazioni vennero ben rappresentate negli interventi alla giornata di studi promossa da “Études photographiques” in occasione della mostra Qu’est-ce que la photographie?, curata nel 2015 da Clément Chéroux e Karolina Ziebinska-Lewandowska al Centre Pompidou di Parigi; tutte accomunate “nel denunciare la dimensione identitaria abusiva della teoria ontologica, che non tiene conto della diversità delle pratiche fotografiche”[23]. In quell’occasione André Gunthert (2016 b) aveva sostenuto che “il problema dell’effetto di presenza cambia radicalmente quando ci rendiamo conto che l’iconografia mobilitata dalle teorie essenzialiste appartiene esclusivamente al registro documentario. Cosa succede quando confrontiamo la tesi ontologica con un’immagine di finzione?” Domanda solo apparentemente problematica, alla quale si può tranquillamente rispondere che non accade nulla di diverso; nessuna distinzione tra fotografia ‘documentaria’ o “di finzione”. In entrambe, permane e vale (ha valore) l’ “effetto di presenza”. Questa è la ragione fondante per cui l’illustrazione pubblicitaria è prevalentemente fotografica e non grafica; perché conferma che le cose così come ci vengono mostrate “sono state là” al momento della ripresa, indipendentemente dal fatto che fossero o meno predisposte dal fotografo per simulare o peggio ingannare l’osservatore, come dimostra del resto l’intera storia della fotografia. Una storia che prende avvio da un’opera fondativa come Le Noyé di Hippolyte Bayard (18 ottobre 1840) con tutto quanto ne è seguito; una fotografia che Gunthert pareva aver dimenticato: quasi una rimozione[24].
In quella stessa occasione lo storico statunitense Joel Snyder dopo aver criticato “le teorie della fotografia degli anni Sessanta e Settanta [che] utilizzano generalmente gli stessi termini e fanno appello al medesimo repertorio di analogie”[25], si scagliava violentemente, sarcasticamente, contro le teorie dell’impronta, riproponendo in modo quasi invariato le tesi esposte in Snyder, Allen (1975), ma giocando con le parole, fingendo di non comprendere l’uso inevitabilmente retorico di quelle analogie e – infine – contraddicendosi quando, nel mostrare i fantasmi fotografici visibili nella veduta de l’Intérieur des Halles, Paris, 1874 di Charles Marville, era costretto a riconoscere che “la nebulosità nella parte inferiore della fotografia non denota nulla, non rappresenta nulla, eppure è stata causata da cose: persone che si muovono, carri che passano, carri trainati da cavalli, ecc.”[26], ammettendo così il rapporto causale tra un dato reale e la sua restituzione fotografica, inevitabilmente mediata dalla propria condizione storico tecnologica.
Anche per Philippe Dubois (2016) non si doveva “mai dimenticare che la novità del dispositivo e la novità del pensiero che esso impegna non sono la stessa cosa. (…) Per tornare al ‘Fotografico’ degli anni ’80, una terza componente caratterizza quest’epoca e questi discorsi: l’affermazione (a volte perentoria, a volte illusoria) dell’autonomia di questa categoria, addirittura, per parlare in termini filosofici, della sua ‘ipseità’, di una sorta di essere in sé. Tutto il discorso che ‘essenzializzerà’ (o peggio: ‘ontologizzerà’) la nuova categoria”, con evidenti riferimenti critici al Barthes de La camera chiara e alla nozione di indice di derivazione peirciana[27] adottato da vari studiosi, tra i quali Dubois stesso ([1990] 1996). Ora lo studioso adottava una prospettiva diversa, ciò che gli consentiva di riconoscere i cambiamenti analitici intercorsi e di avanzare una qualche specie di necessaria mediazione, poiché le indagini storiche sulla fotografia avevano evidenziato “non tanto il principio del ‘fotografico’ come categoria a sé stante, ma quello degli usi della fotografia. Alla domanda «cos’è la fotografia?» segue così quest’altra domanda fondamentale: «cosa può fare la fotografia?» (…) Lo studio degli usi dell’immagine ha preso il sopravvento sullo studio ‘ontologico’ del ‘dispositivo’ e delle sue problematiche. (…) La tecnologia digitale consentirà (o obbligherà, a seconda dei punti di vista) ad avvicinarsi al campo della teoria della fotografia, sia dal punto di vista ‘ontologico’ dell’immagine, sia dal punto di vista ‘pragmatico’ degli usi. (…). E bisogna dire, rispetto alla teoria del ‘Fotografico’, che ciò che è cambiato è solo una cosa, ma ben precisa: la questione ‘genetica’ dell’indice, del «ciò è stato» e della traccia (…). In sostanza, direi che l’avvento del digitale ha consentito di relativizzare, di rimettere al proprio posto questa teoria degli anni Ottanta, limitandola alla sua dimensione ‘genetica’, a questo solo momento del processo di produzione dell’immagine”. Un modo elegante quanto semplicistico di salvarsi l’anima analitica e di aggiornarsi accademicamente, specie nel momento in cui Dubois riconosceva che “l’immagine fotografica digitale contemporanea (…) può essere pensata come rappresentazione di un ‘mondo possibile’ e non di un esserci stato, necessariamente reale.” Una bella conferma (quasi inavvertita) del peso genetico nel determinare i possibili destini di queste due (opposte) categorie di immagini, dal momento che “il mezzo digitale può essere considerato innanzitutto come uno spazio di astrazione che esclude la materialità necessaria all’esistenza dell’indessicalità. (…) Se le immagini digitali operano tramite simulazione e il tratto distintivo dell’oggetto fotografico viene perso al momento del contatto, allora non ci sarebbe motivo di definire le immagini digitali come fotografie. (…) le immagini digitali possono essere considerate immagini fotografiche piuttosto che fotografie, una differenza che è connotata di autoreferenzialità e da un senso di nostalgia postmoderna per il moderno. Questo senso di nostalgia non rimpiange il referente perso all’inizio dell’atto fotografico, ma la rappresentazione del referente stesso nella fotografia convenzionale. (…) la fotografia certifica la presenza di una cosa e ne porta tracce, piuttosto che esprimere una specifica associazione tra la rappresentazione fotografica e la verità o dichiarare che l’indessicalità riflette o, al contrario, distorce la realtà” (Değirmenci 2017).
la novità del dispositivo e la novità del pensiero che esso impegna non sono la stessa cosa
In un contributo recente Maria Giulia Dondero e Barbara Grespi (2024) hanno sostenuto che “è questo monolite [l’indessicalità], generato dalla concrezione di molti equivoci, che entra (finalmente) in crisi con la postfotografia, nel momento in cui la «figura» non si crea più sul negativo, ma il processo di memorizzazione del segnale luminoso e il momento della sua messa in visibilità diventano qualitativamente diversi, perché diversamente accessibili ai nostri sensi (…). È questo il momento in cui la fotografia smette di essere indessicale? Semmai è il momento in cui l’indice si rivela per quello che è ed è sempre stato: un concetto molto più complesso, e all’interno del quale il modello dell’impronta gioca un ruolo tutto sommato marginale.” Quel “dispositivo dell’infinitamente manipolabile e rimodellabile” che è il pixel rappresenta infatti “lo strumento che più si allontana dal mito dell’impronta fotografica come testimonianza di un «è-stato» e di un’aderenza mimetica alla materia del reale.” Che l’indice, e quindi l’indessicalità della fotografia siano qualcosa di più complesso di quanto il riferimento all’impronta (e anche alle sue forme) possa a prima vista lasciare intendere mi pare che lo avessero già ben compreso Dubois ([1983] 1996) e Schaeffer ([1987] 2006) solo per fare due nomi, ma resta il fatto che “le immagini digitali possono essere realizzate senza macchina fotografica, senza chimica, senza lenti, persino senza luce, il che significa che tutta la vecchia retorica sulla fotografia come traccia del reale o che ha una connessione indicale con eventi del passato non deve applicarsi all’immagine digitale nativa. L’idea che le fotografie abbiano una connessione rappresentativa, indicale o significativa con eventi, persone e oggetti nel mondo reale non deve necessariamente valere per le immagini digitali che si basano su segnali elettronici e calcolo” (Rubinstein 2018). Così per meglio comprendere questo aspetto dirimente è indispensabile verificare “se la superficie di contatto (cioè la pellicola o il sensore digitale) perpetui o meno le caratteristiche stesse dell’oggetto fotografico al momento del contatto. Per essere precisi, un’immagine fotografica possiede referenzialità solo fino a che si verifica questa perpetuazione. Inoltre, poiché la nozione di referenzialità dipende esistenzialmente da quella di indessicalità, questa affermazione implica intrinsecamente l’indicalità.” (Değirmenci 2017).
i teorici dei nuovi media annunciarono l’apparente ‘morte’ dell’indice fotografico
§§§§§
La permanenza dell’indice
A questo punto è pur ancora “necessario richiamare qualche banalità, [che] la fotografia obbedisce innanzitutto (…) alle regole dell’impronta: l’impronta, infatti, testimonia la presenza di una cosa o di un insieme di cose, convertendole punto per punto in un oggetto[28] o in un insieme di oggetti semiotici; nel caso della fotografia (…) la corrispondenza ‘punto a punto’ è soggetta a mediazioni, quella della luce e di un dispositivo ottico, ma il risultato, da un punto di vista semiotico, è complessivamente lo stesso: una rete di equivalenze locali tra un segmento di stato di cose e la superficie di iscrizione che ne raccoglie le tracce. (…) La modalità semiotica della fotografia è quella di una traccia su una superficie e, in quanto traccia, adotta il regime dell’impronta”[29].
Quella corrispondenza ‘punto a punto’ è ciò che Deleuze ([1981] 2023: 108) aveva definito “somiglianza produttiva”, esemplificandola proprio nella fotografia; quella che per un filosofo conservatore come Roger Scruton (1981) “non è un’arte figurativa”, di rappresentazione, poiché “una fotografia è una fotografia di qualcosa. Ma qui la relazione è causale e non intenzionale. In altre parole, se una fotografia è una fotografia di un soggetto, ne consegue che il soggetto esiste, e se X è una fotografia di un uomo, c’è un uomo particolare di cui X è la fotografia. (…) quando diciamo che X è una fotografia di Y ci riferiamo a questa relazione causale, ed è in termini di relazione causale che il soggetto di una fotografia è normalmente compreso”. In ciò risiede anche la sua qualificazione storica e non filosofica poiché la fotografia “non dice l’ ‘universale’ (hoîa àn génoito: ciò che sarebbe potuto essere, anche se non è mai stato, e ciò che potrebbe essere, anche se non sarà mai), ma (…) dice tà genómena, l’accaduto, nella sua irriducibile particolarità e transitorietà. La foto non è dunque una rappresentazione trasfigurante e ‘selettiva’ della realtà, ma è ‘trasparente’ rispetto a essa” (Meo 2018). Quella stessa relazione è stata richiamata da Paul Ricoeur a proposito della “solidità di un legame di causalità tra l’indizio e la cosa indicata che Peirce sottolinea nella sua famosa teoria dei segni. (…) In questo l’indizio si oppone all’icona e al simbolo: l’indizio è un segno che perderebbe immediatamente il suo carattere, se il suo oggetto venisse soppresso (il buco della ferita e lo sparo)” (in Changeux, Ricoeur [1998] 1999: 100). La funzione indessicale di traccia implica una relazione causale con la cosa indicata, quindi è inevitabilmente, ontologicamente referenziale (non esiste se non è esistita la cosa indicata, accaduta; la cosa di cui è indizio o traccia). Una fotografia è indizio della presenza dell’oggetto fotografato, poiché senza oggetto da fotografare non può esistere fotografia in senso proprio[30], ma la figura che ne deriva permane anche dopo la sparizione dell’oggetto (nel tempo, nello spazio). Da ciò la sua più pertinente accezione di traccia, che implica causalmente l’esistenza di qualcosa che l’ha determinata, e può permanere anche dopo che il suo agente è scomparso. La Fotografia ha una sua specifica relazione col Tempo e – più in particolare, più intimamente – non con la condizione sostanziale o rappresentativa dell’accadere (che è quanto connota le pratiche digitali), bensì dell’accaduto, di ciò che è stato e quindi, solo per questo, risulta inattingibile, non modificabile.
l’impronta testimonia la presenza di una cosa o di un insieme di cose,
convertendole punto per punto in un oggetto
È questo che “ci consente di parlare di irreversibilità, per la semplice ragione che questa è una relazione temporale con una realtà temporale e quindi irreversibile”[31]. Una posizione teorica di cui possiamo riscontrare una eco anche nelle più recenti elaborazioni ‘quantistiche’ della teoria fotografica, quelle che evidenziano “la separazione tra il momento dell’iscrizione mediante la luce che avviene all’interno della macchina fotografica e il momento dello ‘sviluppo’ (…). In questa frattura la condizione ontologica dell’immagine fotografica si rivela essere la differenza tra due stati incommensurabili. Il principio della fotografia non consiste nella connessione indessicale tra passato e presente, né nella rappresentazione di forme astratte, ma nella presentazione visiva del tempo come internamente diviso. Il requisito della frattura istituisce la possibilità di un’immagine che catturi l’indeterminatezza e l’asimmetria come le condizioni stesse della visualità”[32].
Scrivendo in memoria di Roland Barthes, Jacques Derrida ([1981] 2010) si era chiesto se si dovesse “dire la referenza o il referente? La meticolosità analitica deve essere qui proporzionata alla posta in gioco, e la fotografia la mette alla prova: in essa il referente è visibilmente assente, sospendibile, scomparso nell’unica volta, già passata, del suo evento, ma la referenza a questo referente, diciamo il movimento intenzionale della referenza (…) implica anche in modo irriducibile l’essere-stato di un unico e invariabile referente. Essa implica questo «ritorno del morto» nella struttura stessa della sua immagine e del fenomeno della sua immagine. Cosa che non si produce – o in ogni caso non allo stesso modo, in quanto l’implicazione e la forma della referenza vi assumono tutt’altri giri e rigiri – in altri tipi di immagini o di discorsi, diciamo pure di marche in generale. Fin dall’inizio, in La chambre claire, il «disordine» introdotto dalla fotografia viene attribuito con forza all’«unica volta» del suo referente, una volta che non si lascia riprodurre o pluralizzare, una volta la cui implicazione referenziale è inscritta come tale direttamente nella struttura del fotogramma, quale che sia il numero delle sue riproduzioni e anche l’artificio della sua composizione. (…) ciò che nella fotografia aderisce, è forse meno il referente stesso, nell’effettività presente della sua realtà, che non l’implicazione, nella referenza, del suo essere-stato-unico”.
L’origine causale di ogni fotografia e il suo conseguente significato e valore di traccia, di cui si è detto e sul quale si è ampiamente dibattuto negli ultimi decenni del XX secolo, costituiscono però solo uno degli elementi definitori del suo statuto di esistenza, essendo l’altro (altrettanto determinante) quello dell’irreversibilità del processo di registrazione della traccia sul supporto fotosensibile. Già William Henry Fox Talbot, ricordando le riflessioni fatte sulle sponde di “quel ramo del lago di Como” nell’ottobre del 1833, aveva dichiarato che il suo primo desiderio era stato quello di “far sì che queste immagini della natura si imprimessero da sole in modo duraturo e rimanessero fissate sulla carta!”[33], definendo così l’altra fondamentale componente di ogni immagine che si sarebbe poi detta fotografica, a sua volta stabilmente riconosciuta, ricercata e verificata da ogni sperimentazione tecnologica e riflessione teorica successiva.
il principio della fotografia non consiste nella connessione indessicale tra passato e presente, ma nella presentazione visiva del tempo come internamente diviso
Così ancora Hubert Damish poteva definire la fotografia come “un processo di registrazione, una tecnica di iscrizione, in un’emulsione a base di sali d’argento, di un’immagine stabile generata da una radiazione luminosa”[34]; definizione da cui deriva anche la terminologia ancora utilizzata in ambito catalografico, che descrive il fototipo come immagine fotografica positiva o negativa visibile e stabile ottenuta dopo esposizione e trattamento di uno strato fotosensibile.
L’atto fotografico che ha generato l’immagine, dall’esperienza al gesto, non può essere ri-fatto, l’informazione registrata dal supporto sensibile non può essere sostituita né modificata se non a prezzo della sua cancellazione[35]. È impossibile sostituire materia fotografica con altra materia fotografica dopo il suo trattamento (esposizione – sviluppo – fissaggio), e allora, come già fu alle origini, credo che il problema fondamentale sia sempre quello del fissaggio: può una sequenza numerica considerarsi ‘fissata’ così come la dimensione e la posizione delle molecole d’argento dopo il loro trattamento? La domanda retorica implica l’ovvia risposta negativa, inevitabilmente confermata anche da un esegeta del postfotografico come Fontcuberta, che nel corso dell’intervista più volte citata (Palmiéri 2014), aveva riconosciuto che “la fotografia è un’immagine che si genera su tutta la sua superficie. Si aziona l’otturatore di fronte a una superficie [sensibile] e ciò crea un’immagine che possiamo modificare, su cui possiamo intervenire, ma ogni operazione modificherà l’integrità della superficie: la messa a fuoco, il colore… D’altra parte, con il digitale si va verso una struttura dell’immagine che si avvicina a quella della pittura o della scrittura[36], perché ci sono unità grafiche come i pixel che possono intervenire in modo isolato senza coinvolgere l’intera superficie.”
Adottando una definizione di Umberto Eco (1997: 207-208) possiamo affermare che è proprio l’irreversibilità della registrazione a costituire la “proprietà non cancellabile”, la “condizione necessaria” per l’identificazione della fotografia in quanto tale, essendo che “le proprietà essenziali [non cancellabili] diventano quelle che non bisogna disconoscere se, in un certo contesto, si vuole mantenere aperto il discorso, e che possono essere negate solo a prezzo di ripattuire il significato dei termini che stiamo usando.” Non si tratta perciò di stabilire una inedita nomenclatura, ma di adottare una nuova e più pertinente terminologia, più aderente all’universo di nuove funzioni nel quale ci troviamo immersi.
È opportuno avviare la riflessione a partire proprio dall’uso dell’aggettivo sostantivato “postfotografico” (certo in debito col ‘fotografico’ di Rosalind Krauss) utilizzato per circoscrivere questo scenario[37]; termine quantomeno improprio se non inadeguato perché se accogliamo le suggestioni di Negroponte (1998) e Cramer (2003) a proposito del “post-digitale” allora il “post-fotografico” non dovrebbe applicarsi alla condizione attuale ma semmai al ‘lungo’ Novecento che va dalla commercializzazione delle emulsioni alla gelatina-sali d’argento, alla soglia del penultimo decennio del XIX secolo, sino all’affermazione del digitale. Ricorrere al termine “postfotografia” per nominare le immagini che vivono (si producono, circolano) in ambiente postdigitale mi pare frutto di un equivoco non colto o – meglio – di una mancanza, di una insufficienza che è storica e teorica insieme, e quindi (per conseguenza) terminologica. Questa inadeguatezza rimanda irresistibilmente ai primordi delle sperimentazioni fotografiche, quando in mancanza di meglio, in attesa della parola inedita, le prime “scritture con la luce” erano chiamate “disegni fotogenici”, con conseguente riutilizzo di lemmi mutuati dall’universo delle arti; senza ancora riuscire a dare un nome proprio (e comune) a questi oggetti, a queste immagini così radicalmente, concettualmente diverse dalla tradizione della figurazione manuale[38]. Certo – allora – sarebbe stato culturalmente impossibile, impensabile, identificare le pratiche fotografiche come “postgrafiche” o “postpittoriche”: nessuno ebbe mai la tentazione di chiamare la fotografia “postpittura” e non solo per ragioni storico culturali. Nonostante certe analogie figurative troppa era l’incommensurabilità dei due universi.
“Agli albori del XIX secolo ci furono dubbi su quale nome dare a quelle rozze immagini fatte con la luce, fino a quando il termine adatto ‘fotografia’, partorito da Herschel[39], finì per imporsi. Oggi il problema non è solo terminologico. Non stiamo assistendo alla nascita di una tecnica, ma alla trasmutazione di alcuni valori fondamentali. La sua carcassa rimane intatta, è la sua anima che si sta trasformando, in una sorta di metempsicosi. Non siamo in presenza quindi dell’invenzione di un procedimento, ma della demolizione di una cultura: lo smantellamento di quelle modalità visive che la fotografia ha imposto in maniera egemone per un secolo e mezzo. Inoltre [proseguiva Fontcuberta[40]] dal punto di vista dell’evoluzione nelle discipline dell’immagine, bisogna aggiungere che nemmeno il passaggio dalla pittura alla fotografia nel XIX secolo e quello dalla fotografia alla postfotografia nel XXI secolo si assomigliano. Nel primo caso ci fu una rottura tangibile, mentre nel secondo si è creata una faglia invisibile. Parliamo di una faglia perché le sue conseguenze annullano o rendono obsoleta la tappa precedente.
con il digitale si va verso una struttura dell’immagine che si avvicina a quella della pittura
La fotografia ha solo provocato nella pittura un cambio di rotta, ma non l’ha espunta dalla mappa; tutto il contrario di ciò che è successo tra la postfotografia e la fotografia, perché quest’ultima sembra essere stata fagocitata. E questa faglia si è resa invisibile perché chi la pratica non si è accorto del cambiamento e continua a chiamare fotografia ciò che fa. Ovviamente riconosce i cambiamenti tecnologici nei dispositivi utilizzati e negli spazi sociali di utilizzo, ma l’alterazione profonda è avvenuta di nascosto. Per questo, giustamente, Geoffrey Batchen pensa che non si debba tanto parlare di un ‘dopo’ la fotografia, quanto di un ‘oltre’ o di un ‘più in là’ (beyond). La postfotografia si apposta dietro alla fotografia, che diviene solamente la facciata di un edificio la cui struttura interna si è profondamente rimodellata. Questa struttura interiore è concettuale e ideologica. Per essere precisi, la sostituzione di molte funzioni germinali e delle sue caratteristiche ontologiche è ciò che origina tale condizione postfotografica. Sostituzione che può leggersi anche come superamento: la postfotografia sarebbe ciò che supera o trascende la fotografia. Almeno la fotografia per come l’abbiamo conosciuta fino a adesso.”
Le radicali trasformazioni e le dinamiche di transizione non potrebbero essere sintetizzate in modo più chiaro, ma resta la perplessità a proposito delle ragioni per le quali una nuova entità ontologica dovrebbe essere nominata semplicemente aggiungendo un prefisso a quella precedente. Se – come ha ricordato didascalicamente Fred Ritchin ([2009] 2012) rifacendosi a Mitchell (1992) – la carrozza senza cavalli assunse ben presto il nome aggettivato di automobile, oggi pare invece che si intenda ragionare all’inverso, riconoscere nostalgicamente i legami restanti col fotografico piuttosto che accogliere e sviluppare le radicali differenze indotte dal digitale e dalla rete. Quasi un desiderio di tradizione, di accoglienza di una linea ‘evolutiva’ senza tagli radicali. Ingannati da troppo superficiali somiglianze queste “imprecisioni del linguaggio (…) si manifestano nella forma della paleonimia, ossia, in parole povere, del conservare nomi che non si adattano più alle cose cui si riferiscono” ( Ferraris 2021). Una condizione ben delineata da Andrew Dewdney, per il quale “la scelta tra continuare a resuscitare la fotografia in vari post-abbracci e dimenticarla è netta (…) abbiamo bisogno di un nuovo termine, ma provvisoriamente potremmo chiamarla network image o immagine di Rete. (…) Inquadrare la discussione sulla network image computazionale in termini di post-fotografia significa, per definizione, trattare di qualcosa che viene dopo la fotografia, ma che conserva il discorso del fotografico. Perciò il termine post-fotografia viene qui utilizzato come ripresa della fotografia, piuttosto che come superamento della stessa, una nozione pensata per essere fastidiosa” (Dewdney [2021] 2023: 8, 25, 51).
È indispensabile allora distinguere tra l’attuale contesto – forse post-fotografico, certamente postdigitale – e le immagini che lo abitano e lo connotano; la cui concreta, apparentemente immateriale specificità richiede di essere riconosciuta per le proprie caratteristiche ontologiche e non solo fenomenologiche e pragmatiche (“segnaletiche”[41]). Immagini alle quali pare sempre più necessario assegnare un inedito nome.
Poiché è stata proprio la dicotomia oppositiva irreversibilità/ reversibilità a determinare il “cambiamento che ha sconvolto l’ontologia stessa della fotografia (…) [e] può darsi che la fotografia dovrà essere rinominata in modo diverso” (Fontcuberta in Palmiéri 2014), sarà allora il caso di riproporre l’invito rivolto all’audience da Wim Wenders nel corso di un’intervista alla BBC nel 2018: “Sono alla ricerca di un nuovo termine per questa nuova attività che assomiglia così tanto alla fotografia ma non è più fotografia. Fatemi sapere per favore se avete un nome per essa”[42]. E questo nome – nonostante ed anzi in virtù del suo grande successo anche mediatico – non può essere post(-)fotografia. Non solo improprio dal punto di vista storico culturale, ma soprattutto troppo aperto e incerto nei propri confini semantici, così ampi e informi da generare una confusione forse proficua in termini commerciali e sociologici, ma troppo opaco per consentire una buona riflessione teorica, una comprensione delle sue caratteristiche essenziali, che sono pur sempre quelle su cui se ne fonda l’uso. Né si rivelano di una qualche utilità (se non discorsiva) i numerosi termini alternativi proposti o semplicemente utilizzati in maniera fungibile negli ultimi decenni. “Le etichette attraverso cui si cerca di rendere la qualità delle immagini postfotografiche proliferano” ha riconosciuto Barbara Grespi[43], e si direbbe che questa stessa variabilità terminologica sia sintomo dell’incertezza concettuale nella definizione dell’immagine e del fenomeno.
Che peccato allora non poter usare digigrafia/ digigrafie, termine registrato da Epson France[44] per identificare una tecnologia proprietaria di stampa, sebbene ci si posa augurare che questo nome abbia lo stesso destino di “calotype”, brevettato da Talbot nel 1841 (1847 negli USA), ma ben presto divenuto di uso comune. Oppure, e ancor meglio, si potrebbe adottare l’affascinante softimages (Hoelzl, Marie 2015): immagini governate da software, certo, ma anche immagini soffici, morbide e malleabili.
Che bello sarebbe se qualcuno riuscisse finalmente a inventare il nome della cosa.
§§§§§
Bibliografia citata
| Azoulay 2008 | Ariella Azoulay, The Civil Contract of Photography, London: Zone Books, 2008 |
| Azoulay 2010 | Ariella Azoulay, What is a photograph? What is photography?, “Philosophy of Photography”, 1 (2010), n. 1: 9-13, DOI: 10.1386/pop.1.1.9/7 |
| Azoulay [2015] 2018 | Ariella Azoulay, Civil Imagination: A Political Ontology of Photography. London – New York: Verso, 2015 (trad. it. Civil imagination. Ontologia politica della fotografia. Milano: Postmedia Books, 2018) |
| Barboza 1996 | Pierre Barboza, Du photographique au numérique. La parenthèse indicielle dans l’histoire des images. Paris: L’Harmattan, 1996 |
| Batchen 1994 | Geoffrey Batchen, Phantasm: Digital Imaging and the Death of Photography, “Aperture” ( 1994), n. 136: 46-51. |
| Baudrillard [1995] 1996 | Jean Baudrillard, Le crime parfait. Paris: Editions Galilée, 1995 (trad. it. Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà? Milano: Raffello Cortina Editore, 1996) |
| Bendiksen 2021 | Jonas Bendiksen, The Book of Veles. London: GOST Books, 2021 |
| Bolter, Grusin 1998 | Jay David Bolter, Richard Grusin, Remediation: Understanding New Media. Cambridge (MA): The MIT Press, 1998 (trad. it. Remediation – Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi. Milano: Guerini, 2005)
|
| Borges [1942] 1984 | Jorge Luis Borges, El idioma analítico de John Wilkins, 1942, ora in Id., Tutte le opere, a cura di Domenico Porzio, I. Milano: Mondadori, 1984: 1002-1006
|
| Brückle, De Mutiis 2020 | Wolfgang Brückle, Marco de Mutiis, Post-Photography: What’s in a Name?, “Spectrum – Photography in Switzerland”, September 2019 -December 2020, URL: https://photography-in-switzerland.ch/essays/post-photography-whats-in-a-name (18 12 2024) |
| Changeux, Ricoeur [1998] 1999 | Jean-Pierre Changeux, Paul Ricoeur, Ce Qui Nous Fait Penser. La Nature et la Regle. Paris: Editions Odile Jacob, 1998 (trad. it. La natura e la regola. Alle radici del pensiero. Milano: Raffaello Cortina Editore, 1999) |
| Cinelli 2024 | Rosa Cinelli, Fake, in Grespi, Villa 2024: 252-266 |
| Coulombe 2016 | Maxime Coulombe, Mitchell(s): doute et conventionnalité des images, in Langford , Lavoie 2016, URL: https://revuecaptures.org/node/310 (28 01 2025) |
| Cox 2014 | Geoff Cox, Prehistories of the Post-Digital: Or, Some Old Problems with Post-Anything, in Post-digital Research, “APRJA – A Peer-Reviewed Journal About Content/Form”, 3 (2014), n. 1: 70-75, URL: https://doi.org/10.7146/aprja.v3i1.116087
|
| Cramer 2013 | Florian Cramer, Post-digital: a term that sucks but might be useful, (draft 2), in International research conference Post-digital Research (Aarhus, Kunsthal Aarhus, Denmark, 7-9 October 2013), organised by Christian Ulrik Andersen, Geoff Cox, Tatiana Bazzichelli and Kristoffer Gansing. URL: http://post-digital.projects.cavi.dk/?p=295
(non più accessibile)
|
| Cramer 2014 | Florian Cramer What is ‘Post-Digital’?, in Post-digital Research, “APRJA – A Peer-Reviewed Journal About Content/Form”, 3 (2014), n. 1: 11-24 , URL: https://doi.org/10.7146/aprja.v3i1.116068 (25 02 2025)
|
| Cramer, Jandrić 2021 | Florian Cramer, Petar Jandrić, Postdigital: A Term That Sucks but Is Useful, “Postdigit Science and Education”, 3 (2021): 966–989, URL: https://doi.org/10.1007/s42438-021-00225-9 (25 02 2025) |
| Cullen 2024 | Frances Cullen, Analog(ue) photography, in Expanded Visualities: Photography and Emerging Technologies, “Philosophy of Photography”, 15 (2024), n. 1-2, October: 113 – 121. |
| Damish 1962 | Hubert Damish, Cinq notes pour une phénoménologie de l’image photographique, in La photographie, “L’Arc”, 5 (1962), n. 21, Printemps: 34-37; ora in Id. La dénivelée. À l’épreuve de la photographie. Paris: Seuil, 2001: 7-11 |
| De Kerckhove 2015 | Derricks De Kerckhove, La Photographie augmentée , in Fontcuberta 2015: 138-143 |
| Değirmenci 2017 | Koray Değirmenci, Photographic Indexicality and Referentiality in the Digital Age, in Dan-Eugen Ratiu, Connell Vaughan, eds., “Proceedings of the European Society for Aesthetics”, 9 (2017): 88-115, DOI: 10.1007/978-3-030-71830-5_31 |
| Deleuze [1981] 2023 | Gilles Deleuze, Francis Bacon: Logique de la Sensation. Paris: Editions de la différence, 1981 (trad. It., Francis Bacon. Logica della sensazione. Macerata: Quodlibet, 2023) |
| Derrida [1981] 2010 | Jacques Derrida, Les morts de Roland Barthes, in Roland Barthes, “Poétique”, 12 (1981), n. 47, septembre: 269-292, ora in Marco Consolini, Gianfranco Marrone, a cura di, Roland Barthes, ” Riga”, 20 (2010), n. 30, URL: http://www.rigabooks.it/index.php?idlanguage=1&zone=9&id=772 (28 01 2025) |
| Dewdney [2021] 2023 | Andrew Dewdney, Forget Photography. London: Goldsmiths Press, 2021 (trad. it., Dimenticare la fotografia. Milano: Postmediabooks, 2023) |
| Dewey-Hagborg 2018 | Heather Dewey-Hagborg, Generative Representation, “unthinking photography”, December 17th 2018, URL: https://unthinking.photography/articles/generative-representation (18 11 2024) |
| Dondero, Grespi 2024 | Maria Giulia Dondero, Barbara Grespi, Indici, in Grespi, Villa 2024: 17-35 |
| Donghi 2024 | Lorenzo Donghi, Codici, in Grespi, Villa 2024: 53-70 |
| Dubois [1983] 1996 | Philippe Dubois, L’acte photographique. Paris -Bruxelles: Nathan – Labor, 1983, (trad. it. L’atto fotografico; a cura di Bernardo Valli. Urbino : Quattro venti, 1996) |
| Dubois 2016 | Philippe Dubois, De l’image-trace à l’image-fiction: Le mouvement des théories de la photographie de 1980 à nos jours, in Que dit la théorie 2016 |
| Dvořák 2022 | Tomáš Dvořák, Reconsidering cameraless photography, “Philosophy of Photography”, 13 (2022), n. 1: 3-15 |
| Eco 1979 | Umberto Eco, Lector in fabula. Milano: Bompiani, 1979 |
| Eco 1997 | Umberto Eco, Kant e l’ornitorinco. Milano: Bompiani, 1997 |
| Eder [1891] 1945 | Josef Maria Eder, Geschichte der photographie, in Id. Ausführliches Handbuch der Photographie. Halle: Wilhelm Knapp, 1891 ( trad. ingl. History of Photography. New York -Chichester: Columbia University Press, 1945) |
| Eisinger 1994 | Joel Eisinger, Henry Holmes Smith’s Mother and Son Oedipal Syrup, “History of Photography”, 18 (1994), n.1, Spring: 78-86 |
| Fabbri 2011 | Paolo Fabbri, Atmosfere della fotografia, in La fotografia: oggetto teorico e pratica sociale: relazioni, atti del XXXVIII Convegno dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici ( Roma, 8- 10 ottobre 2010), a cura di Vincenza Del Marco, Isabella Pezzini. Roma: Nuova cultura, 2011, ora in Id., Fabula rasa ovvero gli occhi al cielo, in La camera ibrida, “ARACNE”, n.1, ottobre 2015 |
| Ferraris 2021 | Maurizio Ferraris, Documanità. Filosofia del mondo nuovo. Roma-Bari: Laterza, 2021
|
| Flusser [1983] 1987 | Vilém Flusser, Fur eine Phiiosophie der Fotografie, 1983 (trad it., Per una filosofia della fotografia. Torino: Agorà, 1987) |
| Flusser [1983] 2013 | Vilém Flusser, Pós-história: vinte istantâneos e um modo de usar. São Paulo: Duas Cidades, 1983 ( trad. ingl. Post-History. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013). |
| Flusser 1986 | Vilém Flusser, The Photograph as Post-Industrial Object: An Essay on the Ontological Standing of Photographs, “Leonardo: Journal of the International Society for the Arts Sciences and Technology”, 19 (1986), n. 4: 329-332 |
| Fontcuberta 2011 | Joan Fontcuberta, Por un manifiesto posfotográfico, “La Vanguardia”, 11 maggio 2011 |
| Fontcuberta 2015 | Joan Fontcuberta, dir., La condition post-photographique. Biennale internationale de l’image contemporaine – Le Mois de la Photo à Montréal. Montréal: Kerber Photo Art, 2015 |
| Fontcuberta [2016] 2018 | Joan Fontcuberta,La furia de las imágenes: notas sobre la postfotografia. Barcelona: Galaxia Gutenberg S.L, 2016 (trad. it., La furia delle immagini: note sulla postfotografia. Torino: Einaudi, 2018) |
| Fontcuberta [2022] 2023 | Joan Fontcuberta, Ça-a-été?. Contra Barthes.Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2022 (trad. it. Contro Barthes: saggio visivo sull’indice. Milano: Mimesis, 2023) |
| Gooskens 2012 | Geert Gooskens, Can Digital Pictures Qualify as Photographs?, “American Society for Aesthetics Graduate E-journal”, 4 (20112) n.1, Fall 2011 / Winter 2012: 17-23, URL: https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/07a931/7a74dffd.pdf (17 12 2024) |
| Grespi 2024 a | Barbara Grespi, Fotografia espansa, in Grespi, Villa 2024: 11-16 |
| Grespi 2024 b | Barbara Grespi, Foto(gram)metrie, in Grespi, Villa, 2024: 125-142 |
| Grespi 2024 c | Barbara Grespi, Gesti, in Grespi, Villa, 2024: 177-193 |
| Grespi 2024 d | Barbara Grespi, Ripartire dalla scienza, in Grespi, Villa, 2024: 101-106 |
| Grespi, Villa 2024 | Barbara Grespi, Federica Villa, a cura di, Il postfotografico: dal selfie alla fotogrammetria digitale. Torino: Einaudi, 2024 |
| Gunning 2006 | Tom Gunning, La retouche numérique à l’index: Pour une phénoménologie de la photographie, in La photographie pédagogue / Modèles critiques, “Études photographiques”, 11 (2006), n. 19, Décembre: 96-119, URL : http://journals.openedition.org/etudesphotographiques/1322 (17 01 2025). |
| Gunthert 2014 | André Gunthert, L’image conversationnelle: Les nouveaux usages de la photographie numérique, “Études photographiques”, 19 (2014), n. 31, Printemps, URL: https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/3387 (27 01 2025) |
| Gunthert 2016 a | André Gunthert , Que dit la théorie de la photographie?, in Que dit la théorie 2016 |
| Gunthert 2016 b | André Gunthert, Une illusion essentielle: La photographie saisie par la théorie, in Que dit la théorie 2016 |
| Gunthert 2017 | André Gunthert, Aux sources du Noyé, “L’image sociale: Le carnet de recherches d’André Gunthert”, 31 mai 2017, URL: https://imagesociale.fr/4516 (20 01 2025). |
| Han 2016 | Ji-Yoon Han, Les images ont chaud! La fièvre post-photographique au regard du surréalisme, in Langford , Lavoie 2016, URL: https://revuecaptures.org/node/227 (27 12 2025). |
| Hausken 2024 | Liv Hausken, Photorealism versus photography. AI-generated depiction in the age of visual disinformation, in “Journal of Aesthetics & Culture”, 16 (2024), n.1, DOI: 10.1080/20004214.2024.2340787. |
| Hoelzl, Marie 2015 | Ingrid Hoelzl, Rémi Marie, Softimage. Towards a New Theory of the Digital Image. Bristol: Intellect, 2015 |
| Kölmel, Ströbele 2013 | Mara-Johanna Kölmel, Ursula Ströbele, Introduction, in Id., eds., The Sculptural in the (Post-)Digital Age. Berlin – Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2013: 9-25
|
| Kossoy [1997] 2017 | Boris Kossoy, Hercule Florence: la découverte isolée de la photographie au Brésil. Paris: l’Harmattan, 2017 |
| Langford, Lavoie 2016 | Martha Langford , Vincent Lavoie, dir., Post-photographie? “Captures”, 1 ( 2016), n. 1, URL: https://revuecaptures.org/publication/volume-1-num%C3%A9ro-1 (27 12 2025). |
| Lister 1995 a | Martin Lister, Introductory Essay, in Lister 1995 b: 1-26
|
| Lister 1995 b | Martin Lister, ed., The Photographic Image in Digital Culture. London: Routledge, 1995 |
| Lister 2013 | Martin Lister, ed., The Photographic Image in Digital Culture. London: Taylor & Francis Group, 2013II |
| Lyotard [1979] 1981 | Jean-François Lyotard, La conditione postmoderne. Rapport sur le savoir. Paris: Les Éditions de Minuit, 1979 (trad. it., La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere. Milano: Feltrinelli, 1981) |
| Malavasi 2024 | Luca Malavasi, Social, in Grespi, Villa 2024: 235-251 |
| Manera 2023 | Lorenzo Manera, From photography to synthography. Aesthetic remarks on synthetized images, “Studi di estetica”, IV serie, 51 (2023),n. 3: 205-220, DOI 10.7413/1825864653 |
| Manovich 1996 | Lev Manovich, The Paradoxes of Digital Photography, in Hubertus von Amelunxen, Stefan Iglhaut, Florian Rotzer, eds., Photography after Photography: Memory and Representation in the Digital Age. Amsterdam: OPA, 1996: 57-65 |
| Manovich 2016 | Lev Manovich, What is Digital Cinema? [1996], in Shane Denson, Julia Leyda, eds., Post-Cinema: Theorizing 21st-Century Film. Falmer: Reframe Books, 2016, 2016: 20-50 URL: https://reframe.sussex.ac.uk/wp-content/uploads/2019/05/POST-CINEMA_LO_RES.pdf (03 01 2025) |
| Meo 2018 | Oscar Meo, Gli equivoci di un’“arte media”, ovvero le disavventure filosofiche della fotografia, in Maddalena Mazzocut-Mis, Chiara Spenuso, a cura di, Fermo immagine: arte, vita e mercato della fotografia. Milano: Mimesis, 2018: 17-35 |
| Mitchell 1992 | William J. Mitchell, The Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post-photographic Era. Cambridge – London: The MIT Press, 1992, |
| Monjour 2018 a | Servanne Monjour, De la remédiation à la rétromédiation, in Id., Mythologies postphotographiques. Montréal: Presses de l’Université de Montréal, 2018, URL: https://www.parcoursnumeriques-pum.ca/10-mythologies/chapitre7.html (20 12 2024) |
| Monjour 2018 b | Servanne Monjour, De la retouche au hack: l’imaginaire du code, in Id., Mythologies postphotographiques. Montréal: Presses de l’Université de Montréal, 2018, URL: https://www.parcoursnumeriques-pum.ca/10-mythologies/chapitre15.html (20 12 2024) |
| Monjour 2018 c | Monjour, Le métaphotographique, in Id., Mythologies postphotographiques. Montréal: Presses de l’Université de Montréal, 2018, URL: https://www.parcoursnumeriques-pum.ca/10-mythologies/chapitre10.html (20 12 2024) |
| Negroponte 1998 | Nicholas Negroponte, Beyond Digital, “Wired”, 6 (1998), n.12, December, URL: https://web.media.mit.edu/~nicholas/Wired/WIRED6-12.html
|
| Osborne 2003 | Peter Osborne, Photography in an Expanding Field: Distributive Unity and Dominant Form, in David Green, ed., Where is the Photograph? Brighton: Photoworks/Photoforum, 2003: 63–70 |
| Osborne 2010 | Peter Osborne, Infinite exchange: The social ontology of the photographic image, “Philosophy of Photography”, 1 (2010), n. 1: 59–68, DOI: 10.1386/pop.1.1.59/1 |
| Paglen [2016] 2022 | Trevor Paglen, Invisible Images (Your pictures are looking at you), “The New Inquiry”, 5 (2016), n. 101, December (trad it. Immagini invisibili, in Andrea Facchetti, Francesca d’Abbraccio, a cura di, AI & Conflicts 01. Brescia: Krisis Publishing,2022: 40-55) |
| Palmer 2015 | Daniel Palmer, Lights, Camera, Algorithm: Digital Photography’s Algorithmic Conditions, in Sean Cubitt, Daniel Palmer, Nate Tkacz, eds., Digital Light. London: Fibreculture Book Series, Open Humanities Press, 2015: 144-162. |
| Palmiéri 2014 | Christine Palmiéri, Intervista a Fontcuberta, “Archée”, dicembre 2014 (www.archee.qc.ca, non più accessibile), ora in “Ciel variable”, n. 101, Automne 2015, URL:https://cielvariable.ca/numeros/ciel-variable-101-strates/joan-fontcuberta-problematiques-discursives-de-la-post-photographie-christine-palmieri/ (15 11 2024) |
| Paulsen 2018 | Kris Paulsen, Rogue Pixels: Indexicality and Algorithmic Camouflage, “Signs and Society”, 6 (2018), no. 2: 412-434 |
| Pickup 2016 | Martin Pickup, A Situationalist Solution to the Ship of Theseus Puzzle, “Erkenntnis”, 81 (2016), n. 5: 973-992
|
| Pinotti 2021 | Andrea Pinotti, Alla soglia dell’immagine: da Narciso alla realtà virtuale. Torino: Einaudi 2021 |
| Previtali 2024 | Giuseppe Previtali, Citizenship, in Grespi, Villa 2024: 266-283 |
| Que dit la théorie 2016 | Que dit la théorie de la photographie ? / Interroger l’historicité, actes du colloque Où en sont les théories de la photographie ? (Paris, Centre Pompidou 27 mai 2015), “Études photographiques”, 21 (2016), n. 34, Printemps, URL: https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/3583 ( 21 12 2024) |
| Ritchin [2009] 2012 | Fred Ritchin, After Photography. New York: WW Norton & Company, 2009 (trad. it. Dopo la fotografia. Torino : Einaudi, 2012 |
| Robins 1995 | Kevin Robins, Will Image Move Us Still?, in Lister 1995 b: 29-50 |
| Rubinstein 2013 | Daniel Rubinstein, The Grin of Schrödinger’s Cat: Quantum Photography and the Limits of Representation, in Daniel Rubinstein, Johnny Golding, Andy Fisher, eds., On the Verge of Photography. Imaging Beyond Representation. Birmingham: ARTicle Press, 2013: 33-47 |
| Rubinstein 2015 | Daniel Rubinstein, What is 21st Century Photography?, in “The Photographers’ Gallery Blog”, 2015, URL: https://thesandpitdotorg1.wordpress.com/2015/07/03/what-is-21st-century-photography/ (13 11 2024) |
| Rubinstein 2018 | Daniel Rubinstein, Post-representational Photography, or the Grin of Schrödinger’s Cat, in Ben Burbridge, Annebella Pollen, eds. Photography Reframed: New Visions in Contemporary Photographic Culture. London: Routledge, 2018. URL: https://www.danielrubinstein.net/wp-content/uploads/2018/08/Post-Representational-Photography-or-the-grin-of-Schrodingers-cat.pdf (06 01 2025) |
| Rubinstein, Sluis 2013 | Daniel Rubinstein, Katrin Sluis, The Digital Image in Photographic Culture: Algorithmic Photography and the Crisis of Representation, in Lister 2013: 22-40 |
| Sandbye 2012 | Mette Sandbye, It Has Not Been – It Is: The Signaletic Transformation of Photography, “Journal of Aesthetics & Culture”, 4 (2012), http://dx.doi.org/10.3402/jac.v4i0.18159 (01 03 2025), ora in Joanna Zylinska, Kamila Kuc, eds., Photomediations: A Reader. London: Open Humanities Press, 2016: 95-108
|
| Schaeffer [1987] 2006 | Jean-Marie Schaeffer, L’image précaire: du dispositif photographique. Paris: Éditions du Seuil, 1987 (trad. it. L’immagine precaria : sul dispositivo fotografico, a cura di Marco Andreani e Roberto Signorini. Bologna : CLUEB, 2006) |
| Scruton 1981 | Roger Scruton, Photography and Representation, “Critical Inquiry” , 7 (1981), No. 3, Spring, pp. 577-603, URL: http://www.jstor.org/stable/1343119 (19 12 2024) |
| Shaïri, Fontanille [2001] 2008 | Hamid-Reza Shaïri, Jacques Fontanille, Approche sémiotique du regard dans la photographie orientale: deux empreintes iraniennes, “Nouveaux Actes Sémiotiques”, n.73-75, Limoges, Pulim, 2001, (trad it. Un approccio semiotico dello sguardo fotografico: due impronte dell’Iran contemporaneo, in Pierluigi Basso Fossali, Maria Giulia Dondero, Semiotica della fotografia. Investigazioni teoriche e pratiche d’analisi, Rimini, Guaraldi, 2008: 217-242 |
| Shapley 2011 | Gregory Shapley ,After the Artefact: Post-Digital Photography in our Post-Media Era. “Journal of Visual Art Practice”, 10 (2011), n. 1: 5-20 |
| Signorini 2009 | Roberto Signorini, Appunti sulla fotografia nel pensiero di Charles S. Peirce. S.l., s.n, 2009, URL https://www.sisf.eu/wp-content/uploads/2014/08/Signorini_Peirce_2009.pdf (21 01 2025) |
| Silverman 2015 | Kaja Silverman, The miracle of analogy, or, The history of photography. Stanford, California: Stanford University Press, 2015 |
| Snyder 2016 | Joel Snyder, Photography, Ontology, Analogy, Compulsion, in Que dit la théorie 2016 |
| Snyder, Allen 1975 | Joel Snyder, Neil Walsh Allen, Photography, Vision, and Representation, “Critical Inquiry”, 2 (1975), n. 1, Autumn: 143–69 https://www.jstor.org/stable/1342806?read-now=1&seq=6#page_scan_tab_contents (27 01 2025) |
| Somaini 2016 | Antonio Somaini, Supporti, media, dispositivi, in Andrea Pinotti, Antonio Somaini, Cultura visuale: immagini sguardi media dispositivi. Torino: Einaudi, 2016: 137-192 |
| Soulages 1998 | François Soulages, Du négatif au numérique: rupture ou continuité dans la photographicité ?, in Actes du Colloque du Séminaire Écrit, Image, Oral et Nouvelles Technologies, Le concept de rupture dans les œuvres produites par les nouvelles technologies, Marie-Claude Vettraino-Soulard, dir., Université Paris 7-Denis-Diderot, le 7 mars 1998. Paris: Publications Paris 7, 1998 |
| Talbot [1844] 2016 | W.H.F.Talbot, The Pencil of Nature. London : Longman, Brown, Green and Longmans, 1844 (trad. it., La matita della natura. Madrid: Casimiro libri, 2016) |
| Todorov [1981] 1990 | Tzvetan Todorov, Mikhaïl Bakhtine le principe dialogique. Paris: Seuil, 1981 (trad. it. Michail Bachtin: il principio dialogico. Torino: Einaudi, 1990) |
| Tomas 1998 | David Tomas, From the Photograph to Postphotographic Practice: Toward a Postoptical Ecology of the Eye, “SubStance”, 17 (1988), No. 1, Issue 55: 59-68
|
| Tomas 2015 | David Tomas, Nouveau médium, nouvelle conscience : l’”esprit” post-photographique et l’écologie post-humaine, in Fontcuberta 2015: 130-137 |
| Villa 2024 | Federica Villa, Introduzione: Soggetti all’incrocio, in Grespi, Villa 2024: 197-200 |
| Willemen 2002 | Paul Willemen, Reflections on Digital Imagery: of Mice and Men, in Martin Rieser, Andrea Zapp, eds.,New Screen Media: Cinema/Art/Narrative. London: British Film Institute, 2002: 14-26 |
| Wosk 1994 | Julie Wosk, (review)The Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post-photographic Era by William J. Mitchell, “Technology and Culture”, 35 (1994), n. 3, July: 640-642, DOI: 10.1353/tech.1994.0071
|
[1] Tomas 1998: 64. Quando non sia indicata l’edizione italiana degli scritti citati le traduzioni sono di chi scrive. Le immagini che illustrano il testo sono state prodotte utilizzando i più comuni programmi di IA da testo a immagine, inserendo come prompt le didascalie in calce a ciascuna.
[2] Mitchell 1992: 4. Anche Manovich 2016, che pure avrebbe preso le distanze da Mitchell, affermava che “il cinema non può più essere nettamente distinto dall’animazione. Non è più una tecnologia indicale, ma piuttosto un sottogenere della pittura”. Sulla stessa linea procede anche Cinelli 2024: 258: “fin dal suo momento aurorale, la postfotografia nasce all’insegna del falso, cioè come una condizione in cui l’inesorabilità dello scatto cede il passo a un’idea di immagine lavorabile, componibile in tutte le sue parti come un dipinto.”
[3] Somaini 2016: 147.
[4] Barbara Grespi, 2024a: 16, si è chiesta opportunamente “che statuto avrà un’immagine postfotografica che non deriva ma genera il suo referente?”, un’immagine cioè che raffigura qualcosa di (ancora) non esistente. Una categoria non inedita, anzi da lungo tempo ampiamente popolata di tipologie e generi tanto diversi quali la pittura sacra e mitologica, lo schizzo progettuale e il rendering architettonico, per larga parte connotate da un livello più o meno elevato di realismo mimetico della raffigurazione ma paradigmaticamente lontane da qualsiasi accezione indicale e quindi fotografica.
[5] Per la definizione del concetto si veda Bolter, Grusin 1998, in particolare p. 45 e seguenti.
[6] Cfr. Hausken 2024. Analoghe difficoltà si incontrano anche nel caso di buone riproduzioni di dipinti iperrealisti di autori quali Richard Estes o i più giovani Rudolf Stingel e Yigal Ozeri.
[7] Osborne 2010, dove rielaborava alcuni concetti già formulati in Osborne 2003; corsivo dell’autore.
[8] Azoulay 2008; si veda anche Azoulay [2015] 2018. Alla Azoulay si è richiamato esplicitamente Previtali 2024, per il quale “la postfotografia è al contempo sia qualcosa che si fa che qualcosa con cui si fa qualcosa mentre si partecipa in modo nuovo alla sfera del politico”, così che “il postfotografico deve essere allora inteso prima di tutto come un’occasione, una nuova possibilità d’intervento concessa a un numero sempre maggiore di soggetti spesso relegati ai margini del visibile, a fronte di qualsiasi rilievo sulla maggiore falsificabilità delle immagini digitali.” Opinione interessante e in parte condivisibile ma viziata da una buona dose di romanticismo: non si dovrebbe mai dimenticare che questa possibilità offerta a chi vive nella marginalità del visibile è governata e dalle major del digitale e della rete, e si traduce in controllo e profitto.
[9] Rubinstein, Sluis 2013: 36. Alcune riflessioni lì contenute sono state successivamente sviluppate in Rubinstein 2018.
[10] Barbara Grespi, 2024a, ha segnalato che “Trevor Paglen usa spesso il termine «allegoria» per definire la qualità del visibile algoritmico, e similmente Carolyne L. Kane, in un libro sul colore nell’era digitale parla di «presentazioni allegoriche di dati» per descrivere il risultato della fotografia termica regolata da codici cromatici fortemente simbolici”, che in realtà però sono solo convenzionali. Monjour 2018 c ha poi recentemente proposto di “porre le basi di nuova ontologia del fatto fotografico, ispirata a una struttura visuale di molto antecedente la fotografia: l’anamorfosi.”
[11] Lister 1995, corsivo dell’autore.
[12] Dewey-Hagborg 2018; si veda anche Donghi 2024, in particolare alle pp. 63-67.
[13] Rubinstein, Sluis 2013: 27. Notiamo che così presentato il processo algoritmico di produzione dell’immagine appare come la versione aggiornata dell’apparato di cui parlava Flusser, [1983] 1987: 18, per il quale “le immagini tecniche (…) sono un complesso simbolico astratto”.
[14] Con la curatela del Mois di Montreal Fontcuberta proseguiva per molti versi la riflessione critica avviata nel 2011 con From Here On per i Rencontres de la Photographie di Arles, curati con Clément Chéroux, Erik Kessels, Martin Parr e Joachim Schmid.
[15] Langford, Lavoie 2016. Quella particolare riflessione prendeva le mosse da Robins 1995.
[16] “L’età della tecnica non incomincia oggi, o ieri, ma ha inizio con il primo umano, ossia con il primo animale che, dotato di pollice opponibile, ha incominciato ad avvalersi in modo sistematico (e trasmissibile attraverso le generazioni) di bastoni e di altri supplementi tecnici (…) è stato in quel momento che ha avuto inizio ciò che oggi, inappropriatamente, si chiama «postumano», un termine che presenta come novità un carattere atemporale dell’umano. Quest’ultimo, nascendo dall’incontro tra l’organismo e un apparato tecnico, è sin dall’inizio postumo a sé stesso, ossia, detto altrimenti, l’umanità dell’umano consiste nell’essere sempre più che semplicemente umano.”, Ferraris 2019: 73-74.
[17] Come ha scritto icasticamente Cramer 2013: “Post-digitale: un termine inopportuno ma che può rivelarsi utile”; si veda anche Cramer, Jandrić 2021.
[18] Fontcuberta 2011, ora in Fontcuberta [2016] 2018: 31-46.
[19] Piuttosto incredibilmente Cinelli 2024: 257 ha scritto a questo proposito di “file composto da pixel”: un vero e proprio illuminante caso di “fake” e una bella testimonianza della perdurante separazione tra competenze umanistiche e scientifiche anche in chi si occupa di universi digitali.
[20] Dondero, Grespi 2024: 26.
[21] Manera 2023.
[22] Per un puntuale ed efficace ricostruzione degli antecedenti rimando a Signorini 2009, in particolare al cap.1, Il dibattito sull’indicalità fotografica negli anni Settanta-Ottanta.
[23] Gunthert 2016 a. Le relazioni presentate al convegno Où en sont les théories de la photographie?, che si tenne allo stesso Centre Pompidou il 27 maggio 2015, sono raccolti in Que dit la théorie 2016.
[24] L’autore ne avrebbe poi fornito un’interessante analisi delle fonti iconografiche, ma senza riprendere le questioni ontologiche, in Gunthert 2017.
[25] Snyder 2016. Anche per Gunthert 2016 b “l’entusiasmo teorico che accompagnò la fotografia negli anni Ottanta non aveva solo caratteristiche innovative.”
[26] Snyder 2016, corsivo di chi scrive.
[27] Nell’opinione di Paolo Fabbri (2011) ” il successo di Peirce nell’analisi della fotografia, specialmente negli Stati Uniti, è non a caso coincidente con il momento di successo dell’arte minimalista. Per la critica d’arte americana Peirce offriva in buona misura una buona soluzione, il concetto di indice, il concetto di un’impressione diretta del reale sui sali d’argento, sulle emulsioni, eccetera, una materia e un medium meno concettuale e meno semantico. Cioè secondo me, il successo del concetto di indice e altri collegati è dovuto a una moda del minimalismo la quale non abbiamo nessun interesse a seguire.”
[28] In termini di geometria proiettiva si potrebbe intendere una fotografia come omologia della cosa fotografata.
[29] Shaïri, Fontanille [2001] 2008: 217-242 e note relative.
[30] Ricordo ancora che questa affermazione vale anche per la produzione off-camera, a partire dai disegni fotogenici di Talbot. In parte diverso è il caso di quella tipologia di immagini riunite sotto il nome di cameraless photography di cui ha trattato Dvořák 2022 e l’intero numero monografico di “Philosophy of Photography”, 13 (2022), n. 1.
[31] Soulages 1998, nel quale però l’autore estendeva questa proprietà anche all’immagine digitale.
[32] Rubinstein 2018. Su questi aspetti si veda anche Villa 2024.
[33] Talbot [1844] 2016: [77] 29, con traduzione in parte diversa da quella qui riportata; corsivo di chi scrive.
[34] Damish 1962, che richiamava poi l’attenzione del lettore sul fatto fondamentale “che questa definizione non presuppone l’uso di un apparecchio, né implica che l’immagine ottenuta sia quella di un oggetto o di uno spettacolo del mondo esterno”, in perfetta concordanza con Henry Holmes Smith che, riprendendo un concetto formulato dal suo maestro Moholy-Nagy, aveva riconosciuto che “lo strumento essenziale del processo fotografico non è l’apparecchio ma il materiale sensibile”, cfr. Eisinger 1994. Ancora recentemente Servanne Monjour, 2018 c, ha sostenuto che “indipendentemente dal fatto che sia digitale o su pellicola, l’immagine fotografica non ha mai cessato di essere soggetta al principio fondamentale della fotosensibilità”, non considerando però la sostanziale questione dell’impermanenza costitutiva del digitale, anzi valorizzando “la sua capacità di creare della realtà (…). La foto rimanda a ciò che “sarà” o a ciò che “potrebbe essere”, attribuendosi così una performatività dove il gesto della presentazione, della presentificazione prevale sulla funzione rappresentativa”, giungendo così alla “deindicizzazione del fotografico”.
[35] Prova ne sia che una fotografia, in virtù della sua natura di traccia fisico chimica, non è restaurabile, ciò che invece risulta possibile con quella digitale, rispetto alla quale si può intervenire sui singoli elementi codificati, esattamente riproducibili, ripetibili ad libitum, in un processo che può portare l’intervento sino a sfiorare il limite pericoloso del rifacimento integrale e indistinguibile, secondo un iter sostitutivo che sovrappone l’identità nuova alla preesistente sino a cancellarla senza lasciare tracce. Si tratta della versione attuale del paradosso della nave di Teseo (cfr. Tomaselli 2013), per il quale Angelone 2015 ha proposto una soluzione ineccepibile dal punto di vista logico filosofico ma indifendibile dal punto di vista storico culturale; si veda anche Pickup 2016.
[36] Anche per De Kerckhove 2015 “esiste una differenza tra il ruolo che la luce svolge nell’atto di iscrizione, come nella fotografia analogica, e quello che svolge nell’esecuzione dei comandi di un codice digitale. In modalità analogica, la luce colpisce una superficie preparata e vi lascia la sua impronta. In modalità digitale, la luce viene convertita in caratteri binari e poi riconvertita in luce”, ricorrendo infine, come già Mitchell 1992 o Manovich 2016, all’analogia con la pittura, tanto diffusa quanto insufficientemente meditata.
[37] Va qui almeno registrata la scelta terminologica di Malavasi 2024, che ha parlato della necessità attuale di “guardare alla fotografia sempre meno come a un’attività specifica, ritagliata dal continuum dell’esperienza, e ai suoi prodotti come a un insieme di elementi «puntuali», e sempre più come a un regime espressivo e comunicativo, il fotografico, un «modo di dire» e «di fare», oggi certamente privilegiato, dell’essere sociale. Nel quadro della socialità digitale, l’immagine fotografica narcotizza volentieri una prestazione di ordine referenziale, testimoniale e «auratica» per caricarsi di funzioni che sono, in prima battuta, di ordine dialogico e fàtico.”, corsivo dell’autore.
[38] Per una sintetica antologia terminologica si veda Silverman 2015: 93.
[39] In realtà il termine venne utilizzato per la prima volta da Hercule Florence (cfr. Kossoy [1997] 2017) in un articolo pubblicato il 21 gennaio 1834 e per certo usato da Charles Wheatston in una lettera indirizzata a Talbot il 1 febbraio 1839 (https://foxtalbot.dmu.ac.uk/letters/transcriptDate.php?month=2&year=1839&pageNumber=2&pageTotal=40&referringPage=0 ), quindi in un articolo dedicato a Talbot pubblicato sulla “Vossische Zeitung” di Berlino del 25 febbraio, dall’astronomo Johann Heinrich von Maedler, corrispondente di Herschel (Eder [1891] 1945: 258-259), e finalmente da quest’ultimo in una lettera ancora a Talbot del 28 febbraio di quel fatidico anno (https://foxtalbot.dmu.ac.uk/letters/transcriptDate.php?month=2&year=1839&pageNumber=36&pageTotal=40&referringPage=1), quindi in una sua conferenza alla Royal Society del successivo 14 marzo.
[40] Fontcuberta [2016] 2018: 23-24. Anche in altri punti del testo l’autore parla di “fratture ontologiche” (138), e quindi – coerentemente – di “nuova dimensione ontologica” (170), ma senza problematizzare le inevitabili conseguenze terminologiche.
[41] Cfr. Sandbye 2012; si veda anche https://photomediationsopenbook.net/data/index.html#ch0 (01 03 2025).
[42] Citato in Brückle, De Mutiis 2020. La video intervista è visibile all’indirizzo https://photography-in-switzerland.ch/essays/post-photography-whats-in-a-name (18 12 2024).
[43] Grespi 2024 a. All’elenco esemplificativo approntato dall’autrice, “immagine software, immagine rete, immagine algoritmica, fotografia automatica, iperfotografia, fotografia aumentata, fotografia non-umana”, possiamo aggiungere o richiamare alla memoria anche postphotography (Tomas 1988); post-photography (Mitchell 1992); digital images (Batchen 1994); pseudophotographs (Wosk 1994); iperphotography, meta-image, (Ritchin [2009] 2012); post-digital photography (Shapley, 2011); new photography (Sandby 2012); photographie augmentée, post-graphie (De Kerckhove 2015); softimage (Hoelzl, Marie 2015); imagen-ficción (Fontcuberta ([2022] 2023); fotografia espansa (Grespi 2024 a).
[44] Digigraphie®, registrato nel 2003 presso l’INPI (Institute Nationale de la Propriété Industrielle) e l’OHIM (Office of Harmonization for the Internal Market).